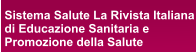VOLUME 62, N°1 GENNAIO-MARZO



EDITORIA
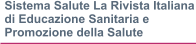
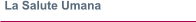





Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria






(Telefono: 075.585-7357/8036 - *Email: centro.cespes@unipg.it
Via del Giochetto, n°6 - 06126 - Perugia, Italia
Piazzale Severi,1 - 06132 -Perugia, Italia

Tullio Seppilli e la psichiatria
Tullio Seppilli and psichiatry
Francesco Scotti
Con la morte di Tullio Seppilli si è chiusa una pagina importante della psichiatria umbra. Non che
la sua vicenda si possa ridurre all’essersi interessato di psichiatria. Nella sua lunga storia di
ricerca antropologica ci sono sicuramente pagine più importanti e contributi che hanno inciso in
modo più significativo sull’accumulo della conoscenza. Ultimamente aveva deciso di esplorare i
suoi vari pezzi di vita per rispondere alla domanda “perché si diventa antropologo”, una domanda
che egli innanzi tutto rivolgeva a se stesso, per soddisfare un bisogno di autocomprensione cui
non aveva mai rinunziato (1).
Se parlo del suo interesse per la psichiatria è perché è ciò che conosco meglio di lui perché
costituiva causa e contenuto dei nostri incontri, diventati più frequenti da quando ero entrato nel
progetto “Per una storia della riforma psichiatrica in Umbria” nel 2010. Tullio Seppilli confessava
di avere da lungo tempo dei “ponti” (così li chiamava) con la psichiatria. In una nota
autobiografica inserita nella presentazione del Quaderno dedicato alla “Nascita del movimento
antimanicomiale umbro” (2) ricordava di aver “partecipato intensamente al movimento con due
differenti ruoli. Da un verso come consigliere della provincia di Perugia del Pci (1970-1980), in
particolare Vice presidente della commissione consiliare per i servizi psichiatrici (la presidenza
spettava, in base ad una prassi consolidata, alla minoranza democristiana), nonché proponente
(in accordo con H. W. Schoen, capogruppo DC) della delibera provinciale per la costituzione del
centro regionale umbro per la ricerca e la documentazione storico psichiatrica. Per altro verso
come direttore dell’istituto di Etnologia e antropologia culturale che seguì il movimento con
numerose tesi di laurea e attività di ricerca, e che ebbe dalla Provincia il compito di analizzare e
sintetizzare le registrazioni delle proposte emerse dalle assemblee popolari realizzate nelle
principali città del territorio provinciale al ne di discutere il progetto di regolamento dei nuovi centri
di igiene mentale, già avviati sperimentalmente dal 1970 in alternativa al manicomio”.
Sottolineava che il suo lavoro nel partito e nell’amministrazione si era svolto in collaborazione con
gli operatori e i sindacati, nelle grandi assemblee dentro e fuori dal manicomio, per delineare le
risposte alternative al bisogno psichiatrico rispetto a quelle offerte dall’istituzione che veniva
contestata.È stata questa una collocazione privilegiata che gli ha permesso di cercare
direttamente, nel processo di trasformazione dell’assistenza psichiatrica, il modo giusto di
integrare il ruolo politico e il ruolo tecnico, la giusta collaborazione tra i rappresentanti delle
istituzioni e gli operatori al fine di costruire una psichiatria rinnovata. Pur non essendo un
operatore della salute mentale si trovava nella posizione di poter verificare l’applicazione dell’idea
che, per affrontare la malattia mentale, non fosse sufficiente una competenza specialistica ma
occorresse la capacità di tenere sotto controllo tutti i meccanismi che fanno di un disturbo
psichico una devianza o una causa di marginalità ed esclusione. Aggiungeva:
“Attualmente mi occupo della ricostruzione storica del movimento per conto delle istituzioni
pubbliche e del sistema sanitario della mia regione lavorando sui documenti e con i protagonisti e
i testimoni di quegli eventi, perché è necessario conservare la memoria di ciò che fu il manicomio,
per costruire ogni giorno risposte adeguate alle situazioni che via via si pro lano per combattere i
tentativi, molto concreti, di tornare indietro” (3).
Se volessimo qui stendere solo un piccolo elenco di ciò che egli ha fatto per la psichiatria,
dovremmo incominciare dalla testimonianza a favore del valore scienti co della conoscenza
psichiatrica in un periodo in cui non andava assolutamente di moda parlare bene della psichiatria:
egli riconosceva al punto di vista psichiatrico una dignità autonoma nella comprensione dei
fenomeni umani. In una concezione sanamente materialistica dava spazio, nella costruzione del
sapere sulla follia, agli apporti che venivano dalla biologia oltre che dalla psicologia. Per lui
custodire la molteplicità delle fonti che confluivano a costituire la psichiatria era un modo concreto
di fondare una critica delle ideologie che portavano a considerare ogni devianza, e quindi anche
quella psichiatrica, come rivoluzionaria e produttrice di una lotta di liberazione, come pure di
quelle posizioni che nega- vano la specificità del disturbo psichico ridotto ad epifenomeno di una
violenza sociale. Questo non gli impediva di riconoscere il legame tra la espressività dei disturbi
mentali, le condizioni di vita materiali e i condizionamenti storico-culturali. Con ciò applicava alla
psichiatria le metodologie con cui si costruisce una antropologia medica.
La seconda caratteristica della sua posizione nei confronti della psichiatria è di aver sempre
pensato ai problemi della salute mentale come parte dei problemi della salute in generale. L’aver
riportato la salute mentale alla salute in generale e l’aver tradotto la conoscenza psichiatrica in
conoscenza antropologica resterebbero tuttavia operazioni parziali e, soprattutto, operazioni
scisse, se non fossero inserite in un progetto politico complessivo, riassumibile nella concezione
della salute come un bene comune, da costruire e preservare.
“La parola beni comuni rinvia all’idea che delle cose appartengono alla collettività e non al
singolo. È una reazione all’individualismo imperante, alla aggressività dilagante, alla competitività
continua che è propria del sistema sociale in cui viviamo. Risponde all’esigenza che alcuni beni
essenziali per la vita dell’uomo debbano sfuggire alla logica della proprietà privata, del mercato e
del pro tto e vadano tutelati dalla legge come beni collettivamente controllati e potenzialmente
disponibili per tutti.
Se si parla di sanità come bene comune ci si riferisce ad un sistema pagato con la fiscalità
generale e distribuito secondo criteri di universalità” (4).
Per fare in modo che un bene diventi bene comune, e non solo bene pubblico, è necessaria la
partecipazione di tutti gli interessati. Rimane aperto il problema di come aprire un servizio
sanitario pubblico a nuove forme di discussione, partecipazione e gestione comunitaria dal basso
dal momento che i meccanismi di iniziativa di controllo dal basso, previsti dalla legge 833, sono
stati aboliti e sostituiti da un controllo dall’alto.
Forse non è un vanto eccessivo affermare che le condizioni per rendere la salute un bene
comune sono state sperimentate in Italia per la prima volta dai movimenti che hanno portato al
superamento del manicomio e alla costruzione di una psichiatria di comunità: la comunità si è
riappropriata del problema non solo della salute mentale ma anche della malattia mentale, perché
la conquista di un nuovo sistema assistenziale si è accoppiata con l’affermazione dei diritti di
cittadinanza; le necessarie specializzazioni non sono state più un limite ad una fruizione
universale dei servizi; la competenza dei cittadini è stata utilizzata per avviare un controllo dal
basso della qualità degli interventi. Forse tutto questo è stato facilitato dallo scarso livello
tecnologico delle prestazioni psichiatriche che non richiedono ospedali particolarmente attrezzati,
e dall’arretratezza del sistema manicomiale, non più compatibile con il livello di sviluppo della
società italiana degli anni ‘60.
A chi trovi eccessivo tale elogio della psichiatria si può dire che questa esemplarità, per altro
distribuita in modo irregolare nella penisola, si è esaurita senza aver prodotto alcun effetto sul
sistema sanitario tradizionale fondato sull’ospedale e sull’impermeabilità a qualsiasi
partecipazione laica sentita come un attacco alla sacralità della specializzazione. Anche dalla
constatazione di questa regressione è scaturita la necessità di una ricerca sulle origini e lo
sviluppo della psichiatria umbra, al ne di cogliere i suoi punti di forza e di debolezza e di
individuare cosa di essa fosse ancora vitale.
La ricerca, avviata nel 2003, è stata portata avanti dalla Fondazione Angelo Celli, di cui Tullio
Seppilli era presidente. L’idea di Seppilli era che andassero recuperate le testimonianze di una
cultura che aveva visto una diffusione soprattutto orale, profondamente legata alle esperienze
pratiche piuttosto che a sapienti elaborazioni teoriche. Questo compito scaturiva da esigenze
etiche che egli chiamava la sua opzione comunista, alla quale si è sempre mantenuto fedele.
“La mia opzione comunista ha giocato per l’antropologia: sul terreno dell’impianto generale, con il
costante richiamo a contestualizzare idee, persone, istituzioni, accadimenti in un orizzonte
storico, in un quadro sistemico; sul terreno operativo, con l’abitudine al lavoro di gruppo, a sentire
gli altri e, almeno in prospettiva, a impostare e finalizzare l’esame empirico delle situazioni e
opzioni pratiche dentro concrete strategie di intervento” (1).
Nella campagna di interviste, che si realizzò negli anni successivi, la particolare attenzione posta
sulla ricostruzione del clima politico e degli aspetti amministrativi risente certamente
dell’esperienza che Tullio Seppilli ha fatto in prima persona nel Consiglio Provinciale di Perugia
negli anni ‘70; in particolare del lavoro svolto per coinvolgere la minoranza democristiana nel
progetto di psichiatria rinnovata, strappandola alla critica ideologica e all’isolamento culturale che
l’avevano caratterizzata no ad allora. È stato questo il primo esempio del compromesso storico
che in quegli anni si stava sperimentando; ma soprattutto è stato un modo corretto di gestire una
egemonia culturale che non negava la propria impostazione marxista ma non si presentava come
dominio bensì come servizio, rinunziando a parole d’ordine per cercare parole condivise.
Nel lavoro per l’elaborazione delle interviste e la raccolta dei documenti che avevano scandito le
varie tappe del processo evolutivo della psichiatria umbra, si sente l’urgenza di far riemergere
dall’oscuramento a cui sembrava condannata la ricchezza di quel periodo, un rinnovamento
spesso celebrato nelle occasioni ufficiali ma sempre meno praticato nell’ultimo decennio. In
questo compito egli impegnava tutte le sue risorse intellettuali e culturali, con lucidità e pazienza.
Chi lo ha frequentato in questi ultimi anni si è reso conto che la sua età avanzata non ha avuto la
qualità di essere qualcosa di troppo, un residuo più o meno utile. Se fosse lecito un uso non
convenzionale dell’aggettivo “avanzato” si potrebbe dire che è un’età disponibile per avanzare.
Questa età, in cui ha raggiunto obiettivi importanti, egli l’ha vissuta nel modo più intenso e
condiviso. La vita di Tullio Seppilli è la prova che la vecchiaia non esiste. Esistono le malattie più
o meno sopportabili ed eventualmente mortali ed esiste una conclusione inevitabile. Se la vita è
una sfida, esemplarmente tale a me sembra sia stata quella di Tullio.
BIBLIOGRAFIA
1.
Seppilli T. Come e perché decidere di “fare l’antropologo”: una personale case history nella
brasiliana São Paulo degli anni Quaranta. L’uomo, Tradizione, Società, Sviluppo 2014; 2:
67-84.
2.
Giacanelli F. Nascita del movimento antimanicomiale umbro. Perugia, Fondazione Angelo
Celli per una cultura della salute, 2014.
3.
Seppilli T. Per un breve pro lo del movimento antimanicomiale italiano negli anni 60-70. In:
Lupattelli P (ed) I Basagliati. Perugia, Crace, 2009.
4.
Seppilli T. (intervista a cura di Nocentini C). Per una salute e sanità bene comune.
Animazione Sociale 2013; 278: 3-12