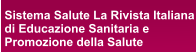VOLUME 62, N°1 GENNAIO-MARZO



EDITORIA
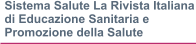
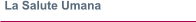





Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria






(Telefono: 075.585-7357/8036 - *Email: centro.cespes@unipg.it
Via del Giochetto, n°6 - 06126 - Perugia, Italia
Piazzale Severi,1 - 06132 -Perugia, Italia

Promozione della salute, salutogenesi, depressione
Health promotion, salutogenesis, depression
Lamberto Briziarelli
Riprendiamo, anche su Sistema Salute, la vecchia, buona abitudine delle testate precedenti, di
richiamare l’attenzione sulla Giornata mondiale della salute. Generalmente lo facevamo nella
rubrica Notiziario, riportando documenti dell’OMS o dedicandovi uno specifico scritto. Questa
volta lo facciamo dedicando un intero numero a una tematica che l’organizzazione
sovranazionale considera giustamente di grande ed attualissima rilevanza, avendo chiamato la
Giornata del 2017 “Parliamo di depressione”.
L’allarme depressione tende a reiterarsi spesso, in forma più o meno estesa e l’ultima
manifestazione si è avuta con la pubblicazione dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità
ma i soli gridi di per sé non garantiscono una migliore presa di coscienza dell’emergenza, né la
garanzia della presa in carico del problema scoperto. Sarebbe perciò opportuno che ci fosse una
costante vigilanza e il monitoraggio delle misure messe in atto, anche per evitare di doversi, ad
ogni allarme, porre la domanda se si tratti dell’aumento di gravità di un fenomeno conosciuto o
dell’essersi finalmente accorti di un problema grave. I dati diffusi dall’OMS nel febbraio 2017
(riferiti all’anno 2015) avevano provocato un notevole allarme nella stampa e ne riferiamo
esaustivamente in un successivo articolo.
I dati forniti da Eurostat nel marzo 2017 denuncerebbero una situazione europea più grave della
media mondiale con quasi il 7% della popolazione che accusa sintomi depressivi. In Italia sembra
andar meglio: solo il 4,3% della popolazione risulterebbe colpita, pari comunque a 2 milioni e
mezzo di persone. Se poi, sempre in Italia, confrontiamo il bisogno di cura con la risposta
sanitaria ad esso, sapremo che solo un depresso su tre riceve un aiuto e che vi è un ritardo di 3-5
anni tra la comparsa del disturbo e la sua presa in carico (1).
A partire da queste considerazioni abbiamo quindi ritenuto di dedicare questo numero alla
depressione, nel tentativo di discutere l’attendibilità di questi dati, alla luce di un’analisi sulle
modalità della loro rilevazione e delle differenze tra le classificazioni dei disturbi che sono state
applicate, il che rende meno trasparenti le cifre comunicate. Così come avere una visione su
cosa si fa nel nostro Paese, attraverso gli scritti di studiosi impegnati nel campo specifico.
Ma, al netto degli sconti che una revisione permetterebbe, ce n’è abbastanza per domandarsi
“che fare?” Una domanda semplice, anche banale, se si vuole ma di difficilissima risposta,
quando la si consideri nella prospettiva della Promozione della salute. Cerchiamo di capire il
perché.
In genere si afferma che ogni problema di patologia dovrebbe essere affrontato attraverso l’analisi
di tre elementi: la patologia (etio-patogenesi, prevenzione, cura e riabilitazione), il contesto
(l’ambiente nel suo complesso fisico e sociale, lo stato dei servizi), la popolazione interessata
(con le misure di incidenza e prevalenza, distribuzione geografica e per stratificazioni sociali,
differenze strutturali, ecc.). È nostro convincimento che troppo poco sia stato fatto in tal senso
rispetto alla tematica di cui ci occupiamo in questo numero. Abbiamo ragione di ritenere che
anche in questo settore delle malattie psichiche abbia fatto aggio la mainstream prevalente nella
sanità: sufficiente attenzione alla cura, anche con operatori qualificati, scarsa propensione alla
prevenzione, poche e sconnesse attività per il recupero e la riabilitazione. La politica sanitaria in
larga misura resta sempre quella della medicina di attesa.
Le ricerche e l’impegno condotti dagli operatori del settore, di cui pure diamo esempi numerosi
negli articoli pubblicati in questo fascicolo e nelle bibliografia e in essi citati, non hanno trovato
seguito sufficiente né un’opportuna quanto necessaria utilizzazione nelle politiche sanitarie.
Nella Promozione della salute, che pure ha avuto un riconoscimento formale nei Piani nazionali di
Prevenzione, lo spazio dedicato alla salute mentale è poco praticato. Mentre è stato affrontato nel
Piano nazionale per la salute mentale, emanato nel 2013 ed aggiornato nel novembre dl 2016 ma
in esso di parla esclusivamente di interventi nel settore della cura; le Linee guida per i servizi
sanitari a ciò riservati seguono ovviamente questo indirizzo. Senza entrare nel merito dei
contenuti di questo provvedimento, è importante sottolineare che esso dimostra ancora la forte
separatezza delle faccende del corpo da quelle della mente (che si dovrebbero pour cause
considerare del tutto assenti, cancellate dalla mente dei legislatori). La permanenza della
divisione è rafforzata da ciò che spesso anche su queste nostre pagine è stato criticato: la scelta
di Dipartimenti dedicati (prima abbiamo giustamente definiti riservati) che avrebbero subito, come
è abbondantemente successo, una certa autarchizzazione, una verticalizzazione che li avrebbe
separati dagli altri servizi, in particolare dalla medicina di base. Questo evento è stato fortemente
stigmatizzato dagli stessi organismi internazionali che hanno indicato nella verticalizzazione dei
servizi sanitari nel loro complesso (si pensi ai Dipartimenti di prevenzione o quelli delle
Dipendenze) un’importante causa della crisi del Servizio sanitario italiano.
Ad onor del vero si deve ricordare che, all’origine, la creazione di servizi dedicati si era resa
indubbiamente necessaria per salvaguardare l’evoluzione del movimento di rinnovamento della
psichiatria, che avrebbe rischiato altrimenti una rapida involuzione; un vincolo necessario alla
sopravvivenza di un apparato giovane che non avrebbe potuto sostenere altri problemi di
assistenza né i frutti negativi di difetti organizzativi nell’assistenza sanitaria di base, come anche
nella lotta fra ospedale e territorio, tuttora non eliminati. Purtroppo nel tempo non è stato risolto lo
stesso problema dell’unità della salute mentale, non essendo riusciti a garantire al loro interno la
coesione delle diverse specialità, realizzate in modo difforme nelle varie regioni: salute mentale,
neuropsichiatria infantile, riabilitazione, dipendenze. Altrettante canne d’organo, che non
connettono l’azione ambulatoriale con l’assistenza domiciliare, il ricovero ospedaliero, le attività
residenziali, gli ospedali ed i centri diurni. L’attuale guazzabuglio delle REMS non aiuta certo la
soluzione dei molti problemi.
Tutto ciò in presenza di un’elaborazione concettuale abbondante, specie a livello internazionale,
accompagnata da prese di posizioni importanti e da documenti applicativi di spessore che hanno
completamente dispiegato teoria e pratica della Promozione della Salute.
Una prima importante svolta si era avuta con la sostituzione, alla logica dei fattori di rischio, di
una maggiore attenzione ai “determinanti di salute”, attraverso la presa in considerazione
dell’insieme dei fattori positivi e negativi che agiscono sulla complessità della persona inserita nel
proprio ambiente di vita e di lavoro; tuttavia il contesto è stato prevalentemente esaminato sotto il
profilo fisico ed i fattori considerati sono stati maggiormente quelli legati ai singoli fenomeni
morbosi, senza una visione globale dell’individuo; in poche parole si è lavorato solo sui
“determinanti di malattia” e poco su quelli “di salute”.
I fattori di origine sociale restavano sottotraccia e sono stati messi in chiaro solo più tardi, con la
creazione, da parte dell’OMS, di una Commissione apposita che ha emesso dopo qualche tempo
un ponderoso ed esaustivo documento, su cui abbiamo dato notizia e di- scusso ampiamente
anche su questa rivista, noto senza dubbio alla totalità dei nostri lettori. Nello spazio di tempo in
cui si giungeva al completamento dei determinanti nelle due versioni, un geniale sociologo,
Antonovski, a completamento di essi ha elaborato una teoria particolarmente interessante,
Salutogenesi, che ha ridefinito in qualche misura la Promozione della salute nella sua
applicazione pratica, esaltando – nella globalità del processo di sviluppo e conservazione della
salute individuale – la collocazione centrale della persona, nella sua interezza, lungo tutto il ciclo
della vita.
Questa teoria è stata pure presentata e discussa nella nostra rivista (2), nonché ben commentata
ed arricchita in un volume (3) che sarà presentato a breve nel nostro Paese nella versione
italiana. Ce n’è dunque materia per lavorare appropriatamente in tal senso ma, purtroppo, la
conoscenza è rimasta solo all’interno degli addetti ai lavori, studiosi ed operatori che fosse- ro,
spesso anche limitatamente a quelli che lavorano attorno al problema dell’Educazione sanitaria e
comunque all’interno della sanità. Non è transitata nei livelli decisionali, sia centrali che periferici
né ha trovato spazio nelle politiche complessive del Paese.
Su questo gap hanno certamente influito, limitando il discorso ai temi basilari della Pro- mozione
della salute (integrazione e interdisciplinarietà, non solo tra sanità e sociale bensì tra sanità e
resto dei settori di governo del Paese, sia a livello centrale che periferico) due fenomeni – uno
politico ed uno scienti co – che hanno largamente influenzato negli ultimi cinque lustri l’evoluzione
della nostra società e non solo del servizio sanitario. Dopo l’eliminazione dei due blocchi
contrapposti e la ne della guerra fredda, con la dissoluzione dell’URSS e del blocco dei paesi
dell’Europa orientale, si è affermato un credo politico unitario, basato sull’idea che solo il
capitalismo fosse il sistema di governo delle società. Su questa base i leader delle due maggiori
potenze mondiali, USA e Regno unito, hanno promosso politiche economiche neo-liberistiche che
hanno incentivato – in nome della libertà di ciascuno e di mercati liberi da ogni vincolo – un
individualismo sfrenato che ha trasformato un motto latino virtuoso (homo faber fortune suae) in
quello ben più pericoloso “homo homini lupus”. In tutto il mondo occidentale si venivano
cancellando progressivamente elementi preziosi affermatisi nel corso della seconda metà del
‘900: coesione sociale, solidarietà, comunità, il termine forse più interessante della Dichiarazione
di Alma Ata. E contemporaneamente veniva portato un attacco violento allo Stato sociale
dell’intero continente europeo e si mettevano in atto tentativi evidenti di smantellamento dei
servizi sanitari nazionali e di quelli pubblici in particolare.
Un concorso all’esaltazione dell’individualismo veniva fornito, forse anche inconsapevolmente,
dalla ricerca scientifica, in particolare nel campo della genetica. Dopo il grande successo di Kary
Mullis con la scoperta della PCR ed il conseguente sequenziamento del DNA, la ricerca
biomedica si è lanciata in una sfrenata individuazione di tutti i possibili siti genetici connessi con
qualche patologia, da quelle più importanti a quelle più rare, determinando un salto all’indietro
rispetto alla necessità della prevenzione e della più generale promozione della salute. In un
prossimo futuro si sarebbe potuto intervenire a monte, individuando precocemente i siti
premonitori e lavorare di conseguenza, magari con pratiche di ingegneria genetica atte a
sostituire i geni difettivi ed anche (perché no? con la clonazione) far nascere individui con un DNA
perfetto. Tentativo già tentato ben prima di Watson e Crick con la teoria di realizzare una razza
pura ed abbiamo visto cosa si è allora combinato! Del tutto recentemente, celebrando il
cinquantennale dalla comparso del volume “La scimmia nuda”, il suo autore ha ripreso l’assioma
della totale assimilazione dell’uomo agli altri animali, sostenendo che nel suo DNA – come in
quello degli altri suoi simili a quattro zampe – siano scritti e predeterminati anche i suoi
comportamenti. Tutto ciò dimenticando ampliamente le smentite ed i conseguenti correttivi
apportati dall’epigenetica al determinismo genetico. Per la verità, con l’enorme avanzamento
della farmacologia, delle tecnologie e dell’implantologia si era fatta già molta strada verso
l’assimilazione del corpo umano ad una macchina: non c’è più bisogno di lottare contro i fattori di
rischio, di controlli precoci, possiamo sostituire qualsiasi pezzo non funzionante, magari anche
con quello di un ani- male appositamente allevato. Banche di organi sono state rapidamente
allestite, talora alimentate addirittura dal traffico di corpi umani e da rapimenti di bambini.
Il lavoro da fare per contrastare questa deriva è senza dubbio enorme, non tanto per una difficoltà
intrinseca ma per la complessità del campo di battaglia, di fronte ai tanti nemici presenti in quasi
tutti i settori della società, la congerie di interessi costituiti che infesta ogni comparto del vivere
civile, la debolezza delle istituzioni, la sfiducia dei cittadini, con l’aggiunta della confusione dei
sistemi informativi e la crescente corruzione. Senza contare la scomparsa degli organismi
intermedi di rappresentanza della popolazione che sono alla base dei populismi e dei sovranismi
che minano la sostanza stessa della democrazia. Si deve necessariamente avere contezza di ciò,
per riprendere un discorso che è stato già fatto, il bisogno di ripercorrere una strada già
intrapresa in passato, dopo i disastri in cui il Paese si è trovato alla fine della seconda guerra
mondiale; mutatis mutandis il quadro complessivo è abbastanza simile, soprattutto perché
manca, quasi nell’intera popolazione, quello che allora consentì di metter mano alla ripresa: la
voglia di fare, la certezza di potercela fare, la speranza nel futuro, la solidarietà, la comunanza dei
ni. Siamo infatti in presenza di una massa prevalentemente fatta di individui isolati, contrapposti e
incapaci (o non desiderosi) di collaborare, un “vulgo disperso” che non sa dove andare, che
insegue falsi miti e falsi profeti, non ha una meta precisa.
L’obiettivo è chiaro, dunque: applicare quanto già prodotto nello specifico prima ricordato; ma
questo sforzo potrebbe non bastare, se non cambia il contesto generale e non saranno riportati in
primo piano gli elementi che portarono alle grandi battaglie sociali degli anni ‘60 e ‘70, che
produssero i risultati di quegli anni: riprodurre una cultura politica, della salute e dello stato
sociale, della solidarietà, sulla base dei valori fondamentali della Carta che sono più che mai
validi, ora forse più di allora.
Rimanendo nell’ambito della sanità deve essere ripresa con forza la lotta per il riordino del
Servizio sanitario e la riorganizzazione del governo della sanità secondo i principi fondamentali
della 833, ristabilendo rapporti virtuosi fra Governo centrale e Regioni, correggendo i difetti
macroscopici dell’aziendalizzazione delle ASL e stabilendo una nuova “ e diversa “governance”
(per usare una parola tanto cara ai decisori attuali) rispetto a quella attuale che mostra falle
enormi in quasi tutta l’Italia.
La storia non torna mai sui suoi passi, come molti dicono ma la società si sviluppa sempre lungo
una strada che ha saliscendi continui, una sinusoide che ha sempre gli stessi alti e bassi, anche
se gli strumenti sono mutati, le persone sembrano fatte diversamente; stiamo navigando di
continuo in un mare che, anche quando appare calmo, ha sempre onde basculanti che hanno un
vertice ed un fondo, che ci obbligano a scendere per poi risalire. Adesso siamo nella parte bassa
dell’onda, sprofondati di molto e bisogna darsi da fare perché il vertice appare assai lontano, più
in alto che mai. Con un impegno di tutti, altrimenti ancora una volta i gridi di allarme rimarranno
lettera morta.
Ma il governo della sanità può, in attesa che si rimetta in moto quest’azione di ben lunga lena,
può fare la sua parte, altrettanto importante. Il Governo centrale dovrà necessaria- mente, come
oramai tutti unanimemente sostengono, riordinare le funzioni ed il funzionamento delle Regioni e
delle Aziende sanitarie; entrambe queste ultime potranno a loro volta, senza alcun ostacolo,
rientrando pienamente nelle loro attuali funzioni, riordinare e riorganizzare sul piano strutturale e
funzionale i servizi attraverso:
•
la completa integrazione fra sociale e sanitario
•
l’integrazione funzionale tra i servizi specialistici
•
il raccordo funzionale fra i servizi specialistici (ospedalieri ed ambulatoriali) e l’assistenza
sanitaria di base
•
il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata
•
la formazione quali-quantitativa di nuovo personale adeguato e la riqualificazione degli
operatori in servizio
•
lo sviluppo di iniziative di Promozione della salute e di Educazione sanitaria della
popolazione nei vari contesti e delle famiglie in particolare. Le indicazioni operative per
quanto sopra sono tutte ben documentate negli articoli che presentiamo in questo numero,
che possono tutte essere realizzate con gli ordinari strumenti del governo, pianificazione
programmazione.
BIBLIOGRAFIA
1.
Ferrannini L et al. Thirty-six years of Community psichiatry in Italy, Journal of nervous and
mental disease 2014; 202(6): 432-439.
2.
Lindstrom B, Eriksson M. From health education to health literacy: Implementing
salutogenesis in educational sciences. Sistema Salute, 60,1, 2016: 41-54.
3.
Lindström B, Eriksson M. The Hitchhikers Guide To Salutogenesis. Salutogenic pathways
to health promotion. Helsinki: Folkhälsan Research Centre, Health Promotion Researchand
the IUHPE Global Working Group on Salutogenesis (GWG-SAL); 2010.